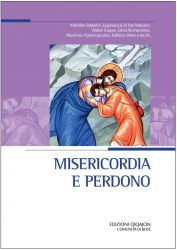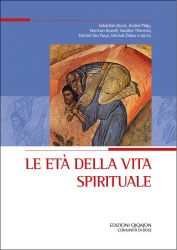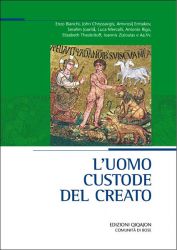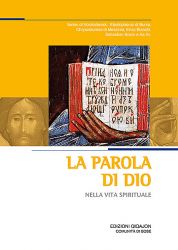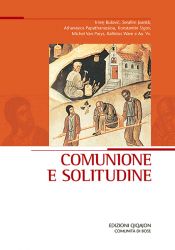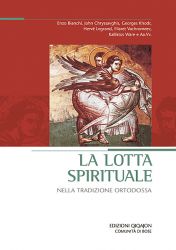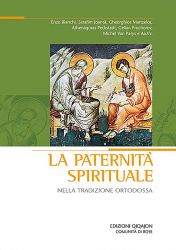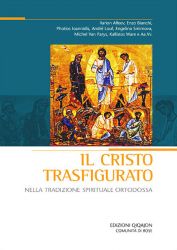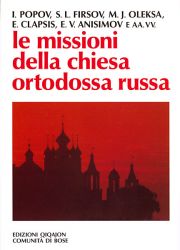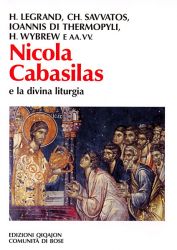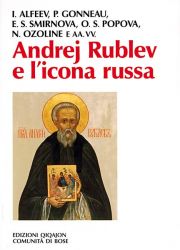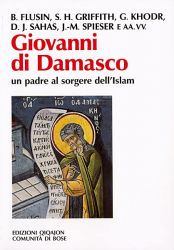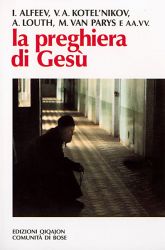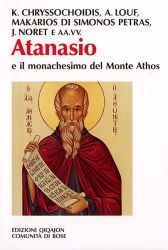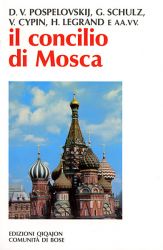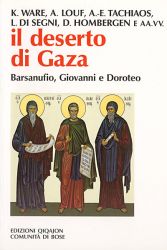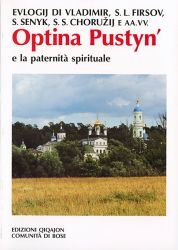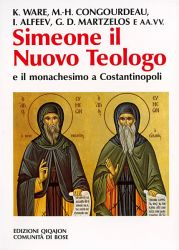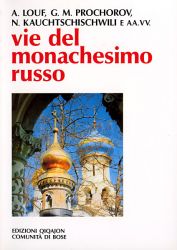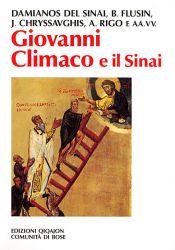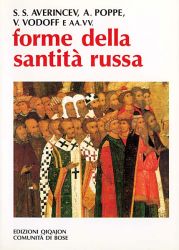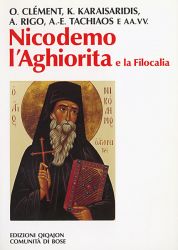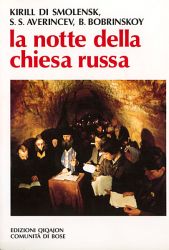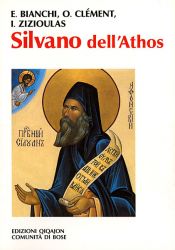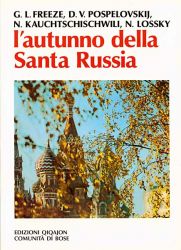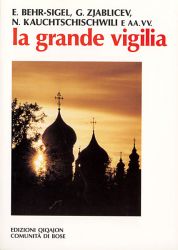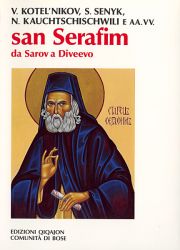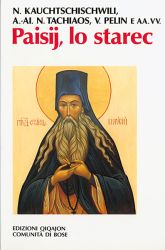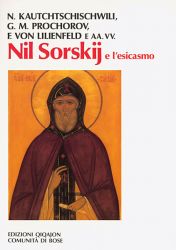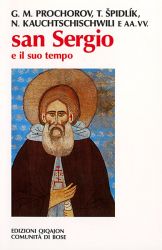Multithumb found errors on this page:
There was a problem loading image 'negozio/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/4/5/456-atti-ortodossi-beati-i-pacifici.jpg'
There was a problem loading image 'negozio/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/4/5/456-atti-ortodossi-beati-i-pacifici.jpg'
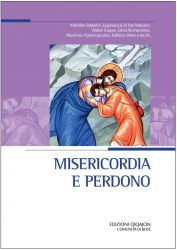 XXIII Convegno ecumenico internazionale
XXIII Convegno ecumenico internazionale
Misericordia e Perdono
Bose, 9-12 settembre 2015
La misericordia è al cuore dell’annuncio cristiano: nell’umanità di Gesù Cristo, Dio si è definitivamente rivelato come colui che è onnipotente nell’amore e nel perdono. Oggi più che mai gli uomini e le donne di ogni orizzonte, in una situazione mondiale precaria, segnata da molteplici ferite, attendono uno sguardo compassionevole sulle loro storie personali e collettive. Le attese che nutrono interpellano la speranza cristiana e spingono le chiese a ritrovare la loro vocazione di testimoni della misericordia del Signore.
Leggere un estratto
Per ordinare
 XXII Convegno ecumenico internazionale
XXII Convegno ecumenico internazionale
Beati i pacifici
Bose, 3-6 settembre 2014
Se è vero che la pace è un dono del Signore, un dono dall’alto, una promessa messianica, resta vero che la violenza e la guerra continuano a rappresentare una grande seduzione per gli uomini. Dobbiamo saper discernere quanto siamo distanti dal comandamento dell’amore reciproco e dall’accogliere quel dono della pace che dovremmo scambiarci e instaurare nel mondo: la chiesa dovrebbe essere una comunità di pace e una scuola di pace per tutti.
Leggere un estratto
Per ordinare
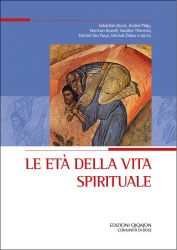
XXI Convegno ecumenico internazionale
Le età della vita spirituale
Bose, 4-7 settembre 2013
La fede cristiana sa parlare a tutte le età della vita, entra nella storia degli uomini e delle donne, svela il senso del passare del tempo, trasmette una speranza che attraversa la catena delle generazioni: discernere questa totalità di senso nel passaggio da un tempo all’altro della vita significa imparare a vivere l’oggi, assumere la responsabilità dell’età adulta per progettare un futuro nuovo.
Leggere un estratto
Per ordinare
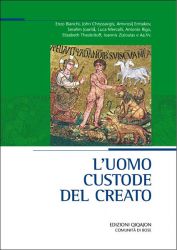
XX Convegno ecumenico internazionale
L'uomo custode del creato
Bose, 5-8 settembre 2012
È qui proposto un itinerario che vorrebbe condurre il lettore a una piena consapevolezza della responsabilità cristiana verso la creazione; e al tempo stesso introdurlo, nel solco della spiritualità dell’oriente cristiano, a ritrovare la profondità e la bellezza del rapporto con le cose e gli esseri viventi, contemplati nella loro destinazione alla salvezza, che è connessa a quella dell’uomo.
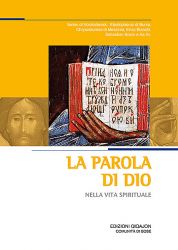
XIX Convegno ecumenico internazionale
La Parola di Dio nella vita spirituale
Bose, 7-10 settembre 2011
Attraverso la parola di Dio ascoltata ogni giorno, la verità, l’amore e la luce di Cristo, presenti nella sacra Scrittura, nutrono la vita della comunità cristiana e di ogni credente, donandogli gioia e pace, speranza e coraggio. L’ascolto della tradizione spirituale ortodossa invita a riflettere sul modo in cui la lettura della Scrittura, fatta attraverso lo Spirito e nella chiesa, sia il vero fondamento di ogni autentica spiritualità cristiana.
Per ordinare
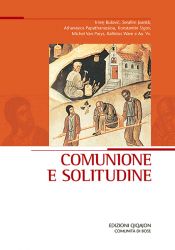 XVIII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
XVIII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
Comunione e solitudine
Bose, 8 - 11 settembre 2010
Gli uomini di oggi vivono spesso una situazione d’isolamento, di solitudine non feconda e, paradossalmente, soffrono di una massificazione che impedisce una vita interiore intensa. L’ascolto della tradizione spirituale ortodossa invita a riscoprire solitudine e comunione quali dimensioni irrinunciabili dell’essere stesso dell’uomo nel mondo: illuminate dalla vicenda di Cristo, manifestano nel mistero della chiesa, una e molteplice, il fondamento cristologico di questa polarità fondamentale della vita spirituale.
Per ordinare
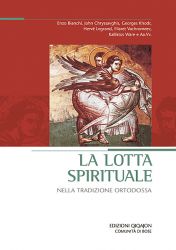 XVII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
XVII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
La lotta spirituale nella tradizione orodossa
Bose, 9 - 12 settembre 2009
La ricerca di Dio richiede una lotta incessante contro tutto ciò che tenta di distrarre il credente dalla comunione con il Signore, una lotta per escludere dal cuore ogni pensiero che sia d’ostacolo alla memoria Dei. Il cristiano non lotta contro gli altri uomini, con tutti cerca di costruire vie di pace, ma lotta contro le proprie passioni, contro l’idolatria di se stesso, l’egoismo, contro lo spirito di divisione che sempre minaccia la comunità dei credenti e le chiese.
Per ordinare
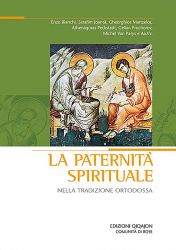 XVI Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
XVI Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
La paternità spirituale
nella tradizione orodossa
Bose, 18 - 21 settembre 2008
La prassi della paternità spirituale è il terreno in cui le Chiese misurano l’unità che già sperimentano nella costante preoccupazione della trasmissione della vita di fede come il bene più prezioso, che ha bisogno di padri e madri spirituali che con fedeltà e intelligenza, con pazienza e misericordia sappiano farsi interpreti della paternità di Dio come Gesù Cristo l’ha narrata nella sua vita tra gli uomini.
Per ordinare
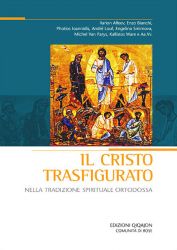 XV Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
XV Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
Il Cristo trasfigurato
nella tradizione spirituale ortodossa
Bose, 16 - 19 settembre 2007
È qui documentato il percorso compiuto da cristiani delle diverse tradizioni volto a cogliere il mistero della Trasfigurazione in tutta la sua profondità, ma anche nel suo significato per gli uomini del nostro tempo … La Trasfigurazione è mistero di trasformazione: del nostro corpo di miseria, destinato a diventare un corpo di gloria, ma anche del corpo ecclesiale, ancora lacerato dalle divisioni e tuttavia chiamato a mostrare nell’unità perfetta dell’amore la Triunità del mistero di Dio “amante dell’uomo”.
Per ordinare
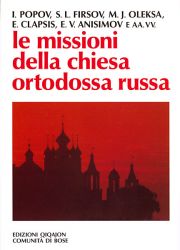 XIV Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
XIV Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
sezione russa
Le missioni della chiesa ortodossa russa
Bose, 18 - 20 settembre 2006
L’essenza della chiesa è il dono della vita di Dio fatto agli uomini in Cristo. La chiesa ortodossa russa ha sempre manifestato questa realtà spirituale ed escatologica nella sua vita liturgica, nella sua storia di santità: “Acquista lo Spirito, e mille intorno a te saranno salvati”, annunciava san Serafim di Sarov. Ma questo dono spirituale ha saputo anche trasformarsi in un’avventura umanissima, nell’annuncio del vangelo nelle mille lingue e culture che popolano gli immensi spazi del nord e della Siberia, fino alla Cina e al Giappone, dal medioevo alle soglie della Rivoluzione d’ottobre e fino ai nostri giorni: nei grandi santi missionari russi l’incontro con la buona novella ha saputo farsi ascolto della ricerca di Dio che abita ogni uomo e ogni cultura. Il XIV Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa ha cercato di mettersi in ascolto della vita missionaria della chiesa russa, proprio in un tempo come il nostro in cui la domanda di senso che abita l’uomo contemporaneo non può essere elusa dai cristiani.
Per ordinare
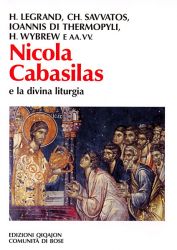 XIV Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
XIV Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
sezione bizantina
Nicola Cabasilas e la divina liturgia
Bose, 14 - 16 settembre 2006
Nicola Cabasilas (1320/22-1400 ca.) fu un uomo talmente radicato nel suo tempo che è possibile abbozzare un quadro del xiv secolo bizantino a partire dalla sua vita. Personalità colta e poliedrica, fu un grande umanista, partecipò attivamente alla vita politica come consigliere dell’imperatore Giovanni VI, fu amico di Gregorio Palamas e suo difensore, intervenne a difesa dei poveri. Questo laico, così attivo nella società del suo tempo, fu anche un eminente teologo e un grande mistico. Il Convegno ecumenico internazionale di Bose, di cui qui pubblichiamo gli atti, si è soffermato in particolare sul suo Commento della divina liturgia, esposizione descrittiva della liturgia bizantina e saggio teologico sul sacramento eucaristico. All’analisi di quest’opera ha fatto seguito una riflessione sulla prassi liturgica bizantina odierna e sulla ricezione dell’ecclesiologia eucaristica nella chiesa cattolica. Il pensiero di Cabasilas, uomo fedele alla tradizione e fedele al suo tempo, ha stimolato interrogativi, suggerimenti, proposte per vivere oggi la divina liturgia nella fedeltà alla tradizione.
Per ordinare
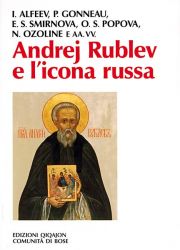 XIII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
XIII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
sezione russa
Andrej Rublev e l'icona Russa
Bose, 15-17 settembre 2005
"La contemplazione dei santi russi nasce dal silenzio della preghiera e delle lacrime, e ritorna al silenzio colmo di stupore e gratitudine per le meraviglie dell'amore di Dio! Ma la bellezza contemplata nel silenzio dell'orazione si riverbera nelle forme colme di grazia delle sante immagini: la teologia dell'antica Rus' è una teologia della bellezza. Nelle icone del santo monaco Andrej Rublev noi contempliamo un'esegesi liturgica e spirituale, che ci fa penetrare nelle profondità del mistero di Cristo"
Enzo Bianchi
I saggi presentati alla sessione russa del XIII Convegno ecumenico di spiritualità ortodossa offrono un'aggiornata messa a punto degli studi sulla vita e l'opera del grande iconografo Andrej Rublev (1360 ca. - 1430 ca.), e aprono prospettive nuove per l'interpretazione del senso dell'icona, dai padri al pensiero religioso russo del xx secolo. Completa il volume una ricca documentazione iconografica.
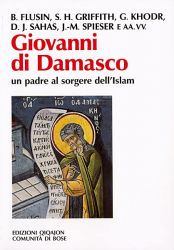 XIII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
XIII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
sezione bizantina
Giovanni di damasco un padre al sorgere dell'Islam
Bose, 11-13 settembre 2005
Durante il VII secolo della nostra era una nuova entità politica e religiosa, l'Islam, si affaccia sulla scena del Medio oriente, culla della fede cristiana. Nella capitale omayyade di Damasco, quindi ormai al di fuori dei confini dell'impero cristiano, nasce Giovanni Damasceno, noto anche come Ibn Mansúr, un greco in un contesto arabo, o un arabo di cultura greca, prima funzionario alla corte califfale e poi monaco nel monastero di San Saba in Palestina. Nella crisi del suo tempo, e di fronte all`altro" che emerge, Giovanni elabora una sintesi di teologia ortodossa tra le più efficaci, canta la sua fede componendo un ricco repertorio innografico, difende la legittimità delle icone. Tutto questo però senza esimersi dal confronto con quel "nuovo", l'Islam, che egli tenta di comprendere. A lui e alla sua epoca così cruciale e, per molti versi, ancora così attuale, è stata dedicata la sessione bizantina del XIII Convegno ecumenico internazionale di Bose di cui presentiamo qui gli atti.
Per ordinare
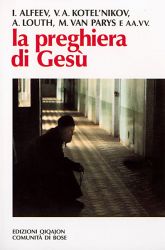 XII Convegno ecumenico internazionale
XII Convegno ecumenico internazionale
di spiritualità ortodossa
sezione russa
La preghiera di Gesù nella spiritualità Russa del XIX secolo
Bose, 16-18 settembre 2004
Fedele discepola di una millenaria trasmissione della vita secondo lo Spirito, la tradizione ortodossa russa conosce, dopo l'edizione della Filocalia slava di Paisij Velickovskij (1793), una straordinaria fioritura della pratica della preghiera di Gesù "fatta con arte nel cuore" e la nascita di una teologia spirituale aperta al confronto con l'occidente e con la filosofia moderna. Da Ignatij Brjancaninov a Teofane il Recluso, dagli starcy di Optina all'anonimo pellegrino, gli autori russi si interrogano sui complessi meccanismi che dalla dispersione della mente conducono all'unificazione interiore, fino a introdurre tutto l'essere dell'orante in un dialogo continuo con Dio. Gli atti del XII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa percorrono le intersezioni tra modernità e tradizione patristica, riscoprendo, come si è espresso il patriarca Alessio li, "la grazia dell'esperienza di preghiera dei santi asceti russi" quale fermento capace anche nell'oggi "di arricchire qualsiasi tradizione cristiana che voglia attingervi, mantenendo il legame con la vita della chiesa indivisa del primo millennio".
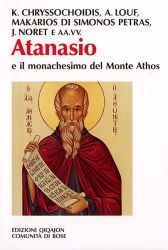 XII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
XII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
sezione bizantina
Atanasio e il monachesimo del monte Athos
Bose, 12-14 settembre 2004
Una tradizione cristiana e monastica millenaria, custodita da una penisola del mar Egeo: questo è innanzitutto la santa montagna dell'Athos, ancor oggi sinonimo di vita spirituale e di ricerca di santità. Da quando vi siritirarono i primi cercatori di Dio, nella solitudine, seguiti dal fondatore del primo cenobio, Atanasio della Grande Lavra, questo lembo di terra ha continuato ad attirare cristiani provenienti dalle regioni più lontane, divenendo luogo di incontro di tradizioni diverse e testimone dell'essenziale che tutti accomuna: la ricerca del volto di Dio. Cristiani provenienti dai paesi tradizionalmente ortodossi, come georgiani, serbi, bulgari, romeni e russi si sono uniti ai monaci greci e hanno trovato sulla santa montagna un luogo comune in cui innalzare a Dio un'unica, polifonica preghiera. E a questo coro hanno voluto unirsi anche i latini che, per almeno tre secoli, hanno contribuito a questa multiforme bellezza. Il XII Convegno ecumenico internazionale di Bose di cui presentiamo gli atti ha voluto, a circa mille anni dalla morte di Atanasio, rimeditare la ricca tradizione athonita, per riascoltarne il messaggio sempre attuale.
Per ordinare
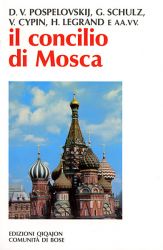 XI Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
XI Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
sezione russa
Il concilio di Mosca
Bose, 18-20 settembre 2003
II concilio della chiesa ortodossa russa, celebrato a Mosca tra il 1917 e il 1918 con la partecipazione di tutte le componenti ecclesiali, fu "uno degli eventi più importanti della chiesa russa nel xx secolo",come si è espresso il patriarca di Mosca Aleksij II nel messaggio all'XI Convegno ecumenico internazionale di Bose, di cui il presente volume raccoglie gli atti. Vero e proprio "spartiacque epocale" tra il crollo dello zarismo e l'epoca delle persecuzioni, il concilio di Mosca rappresenta un momento di sintesi della tradizione, una fonte d'ispirazione per le chiese nella ricerca di vie nuove di dialogo e di risposte comuni alle sfide del mondo contemporaneo. I migliori specialisti ci offrono qui la presentazione, basata su documenti d'archivio, del ricco e incompiuto dibattito conciliare, la storia della ricezione del concilio e una riflessione teologica a più voci sulla conciliarità quale può essere vissuta oggi nelle chiese.
Per ordinare
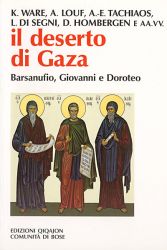 XI Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
XI Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
sezione bizantina
Il deserto di Gaza
Bose, 14-16 settembre 2003
Nella letteratura monastica il deserto è una realtà spirituale prima che geografica: è il luogo in cui uomini e donne cercano Dio, coltivando la carità fraterna. Deserto sono le sabbie egiziane, deserto può diventare la grande città di Costantinopoli, deserto è la regione di Gaza, snodo di importanti vie di comunicazione. Qui fiorirono tre delle figure più originali della tradizione monastica orientale: Barsanufio, Giovanni e Doroteo. Tre figure singolari per la loro esperienza di fede, per i rapporti che le legavano, per la forma di vita solitaria e nel contempo di comunione cui rimasero fedeli. Barsanufio e Giovanni furono reclusi, ma la loro fitta corrispondenza, intessuta grazie al prezioso servizio del loro igumeno Serido, testimonia di una rara capacità di relazione. In una forma monastica esteriormente opposta visse invece il loro discepolo Doroteo, cenobita e fondatore di un luogo di cura per ammalati; ma quella forma altra non gli impedì di sentirsi pienamente discepolo dei due grandi anziani. Il Convegno ecumenico di cui qui presentiamo gli atti ha cercato di ridare voce a questi monaci e alle loro singolari vicende personali che pure li resero partecipi di una medesima esperienza di vita.
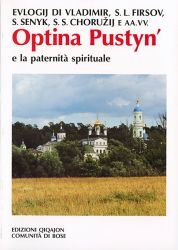 X Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
X Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
sezione russa
Optina Pustyn' e la paternità spirituale
Bose, 19-21 settembre 2002
La ricerca assidua dell'intimità con Dio nella solitudine conduce a volte alla fioritura di una comunità di fratelli in dialogo con le attese e le domandedegli uomini. Un simile incontro tra storia e spiritualità ha caratterizzato nel xix secolo l'esperienza del monastero della Presentazione della Vergine al Tempio di Optina, nella provincia russa di Kaluga. Quasi tutti i grandi protagonisti della cultura russa moderna, da Kireevskij a Gogol', da Tolstoj a Dostoevskij, da Solov'ev a Florenskij, hanno sostato presso le mura di questo monastero. I saggi del volume, presentati al Convegno ecumenico internazionale dedicato a Optina, ripercorrono la genesi di questa appassionante avventura umana e spirituale, fino al tragico epilogo in epoca sovietica e alla rinascita degli ultimi anni. Gli starcy di Optina seppero raggiungere un equilibrio tra desiderio di Dio e amore della terra, particolarmente eloquente per l'inquieta ricerca di senso dell'uomo contemporaneo. Un equilibrio che richiede un'attenzione e una vigilanza continue, ma soprattutto fede e speranza: in Dio, ma anche negli uomini.
Per ordinare
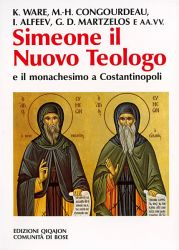 X Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
X Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
sezione bizantina
Simeone il nuovo teologo e il monachesimo a Costantinopoli
Bose, 15-17 settembre 2002
Vivere il deserto dell'esperienza monastica al cuore della città può sembrare paradossale a chi associa al termine monachesimo le aspre immagini del deserto egiziano, siriano e mesopotamico, o gli anfratti della penisola athonita. Ma una tale esperienza di deserto al cuore della città - della grande città di Costantinopoli - è quanto hanno vissuto generazioni di padri del monachesimo orientale, da Teodoro Studita, a Paolo Everghetinos a Simeone il Nuovo Teologo. È a questa esperienza così singolare e in particolare alla figura di Simeone il Nuovo Teologo che è stato dedicato il Convegno ecumenico internazionale di cui questo volume contiene gli atti. Dai contributi che cercano di illustrare il contesto, il pensiero e l'irradiamento di un autore così originale come il Nuovo Teologo - solo recentissimamente riscoperto - emerge un'esperienza spirituale di un'intensità tale da persuadere chiunque che, nei remoti deserti come là dove si affolla la vita degli uomini, è possibile vivere il Vangelo all'unica condizione di mettere in gioco il proprio cuore.
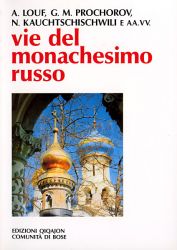 IX Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
IX Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
sezione russa
Vie del monachesimo Russo
Bose, 20-22 settembre 2001
Al cuore dell'ortodossia russa incontriamo l'esperienza della vita monastica. Il monaco russo è segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo, umile intercessore per i fratelli, peccatore con i peccatori, ma anche testimone del perdono e della misericordia di Dio fino agli inferi. Il volume, che raccoglie le relazioni presentate al IX Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa, traccia un appassionante itinerario storico e spirituale attraverso tre dimensioni essenziali del monachesimo russo: la vita interiore e la preghiera, la comunione fraterna, l'attesa del Signore, esperienza radicale di una distanza amorosa dal mondo che è condizione per dire una parola profetica all'uomo contemporaneo. Sono le "Vie del monachesimo russo", memoria di un cammino millenario, ma soprattutto compagnia nell'oggi alla sofferenza e alla sete di senso del nostro tempo.
Per ordinare
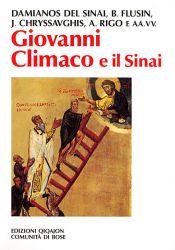 IX Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
IX Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
sezione bizantina
Giovanni Climaco e il Sinai
Bose, 16-18 settembre 2001
Mentre l'area del Vicino oriente attraversava uno dei passaggi epocali che più hanno inciso sulla sua fisionomia politica e religiosa - il sorgere e l'espandersi dell'Islam -, sul monte Sinai, che da secoli ospitava una delle colonie monastiche più antiche, conduceva la sua lotta spirituale Giovanni il Sinaita, noto anche come "Climaco". Prima solitario e poi igumeno del famoso monastero, Giovanni raccolse il frutto della sua ricerca spirituale in quello che è certamente il classico per eccellenza dell'ascesi cristiana: la Scala del paradiso, vero e proprio manuale della vita spirituale che i monaci, e non solo, d'oriente e d'occidente hanno letto, copiato, tradotto, commentato. I contributidel Convegno ecumenico internazionale di Bose, dopo aver delineato l'ambiente sinaitico attraverso i secoli e ritracciato la biografia del Climaco e i temi cruciali del suo pensiero, rendono conto dello straordinario irradiamento della sua opera in ogni parte del mondo cristiano.
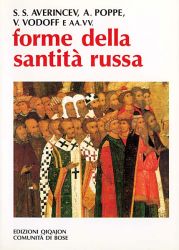 VIII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
VIII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
sezione russa
Forme della santità Russa
Bose, 21-23 settembre 2000
Il santo è l'evangelo fatto carne in un uomo, in una donna, è memoria vivente ed efficace dell'evangelo nella storia. Ma la via della santità è anche la via verso l'unità: la comunione di chiese sorelle. "I santi", diceva il metropolita Evlogij, "sono cittadini della chiesa una e universale". Gli studi qui raccolti, presentati all'VIII Convegno ecumenico di spiritualità ortodossa, restituiscono le forme di quella teologia della bellezza realizzata nelle vite dei santi russi, nello splendore delle icone, nella contemplazione silenziosa del "deserto" del nord: umanità cristianizzata, canto di salvezza e profumo di misericordia per tutte le creature. I santi della chiesa russa, dai principi Boris e Gleb uccisi all'alba della Rus' cristiana fino ai martiri del xx secolo, sono un'immagine viva della pazienza di Cristo e della carità di Dio!
Enzo Bianchi
Per ordinare
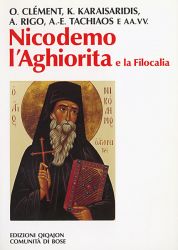 VIII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
VIII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
sezione bizantina
Nicodemo l'Aghiorita e la Filocalia
Bose, 16-19 settembre 2000
Vi sono periodi nella storia in cui è necessario tornare allefonti per purificare la vita della chiesa, dalla sua spiritualità fino alle sue istituzioni più concrete. E quanto avvenne alla fine del xvin secolo in Grecia grazie alla straordinaria figura di Nicodemo l'Aghiorita (1749-1809). Per merito di questo semplice monaco, che recatosi al Monte Athos vi rimase fino alla fine dei suoi giorni, furono compilate ed edite alcune tra le opere più importanti della tradizione orientale. Le relazioni presentate al convegno ecumenico internazionale di Bose ci restituiscono l'autentico profilo storico e spirituale di san Nicodemo, e ci aiutano a capire per quale ragione la Filocalia, da lui compilata assieme a Macario di Corinto, sia un testo fondamentale per la vita spirituale di tutti i cristiani.
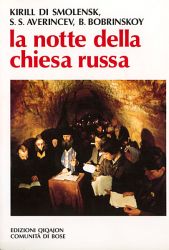 VII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
VII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
La notte della chiesa russa
Bose, 15-18 settembre 1999
"Sentinella, a che punto è la notte?" (Is 21,11) è la parola risuonata all'apertura del VII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità russa, dedicato a "La chiesa ortodossa russa dal 1943 ai nostri giorni", che ha visto riuniti a Bose storici, teologi e uomini di chiesa di tutta Europa. Sono gli oscuri anni successivi alla momentanea tregua, in nome della "guerra patriottica", nelle ostilità aperte contro i cristiani, gli anni delle dure persecuzioni chrusceviane, del dialogo ecumenico che ha accompagnato e seguito il Vaticano li, del fragile e coraggioso risveglio degli anni settanta, fino alle celebrazioni del millennio del battesimo della Rus'. Per i cristiani sono gli anni del "martirio bianco", dell'internamento negli ospedali psichiatrici, della privazione delle relazioni umane, del lavoro, della libertà. Queste pagine evocano urla nel silenzio, grida di un amore ferito ma non vinto, lacrime che intercedono perfino per l'aguzzino.
Enzo Bianchi
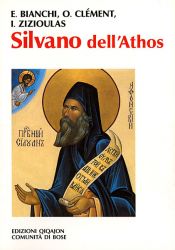
Colloquio ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
Silvano dell'Athos
Bose, 3-4 ottobre 1998
Queste pagine documentano l'evento di un incontro. Non solo quello tra cristiani di tutte le confessioni - vescovi e monaci d'oriente e d'occidente, storici, teologi, patrologi, uomini e donne spirituali di tutta I'oikoumene riuniti a Bose per un Colloquio - ma anche, e soprattutto, l'incontro tra lasete di Dio dell'uomo di oggi e l'umile certezza della fede di un santo senza frontiere: Silvano dell'Athos (1866-1938) ha saputo destare in un numero sempre più vasto di cristiani di questo secolo quella consolazione dello Spirito che penetra anche nelle più oscure profondità del cuore umano e vi sussurra una parola di pace. "Tieni il tuo spirito agli inferi e non disperare" è la rivelazione avuta da Silvano e nel contempo il messaggio attualissimo che dalla Santa Montagna dell'Athos riecheggia in tutto il mondo. Le sue valenze spirituali, cristologiche, ecclesiologiche sono qui approfondite con la sapienza della mente e il calore del cuore, fino a delineare un orizzonte di speranza, la comunione suscitata dall'amore di Dio e promessa all'umanità intera.
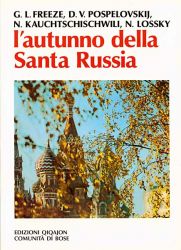 VI Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
VI Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
L'autunno della santa Russia
Bose, 16-19 settembre 1998
Al martirio della chiesa ortodossa russa tra il 1917 e la fine della seconda guerra mondiale è stato dedicato il VI Convegno ecumenico internazionale di spiritualità russa (Bose 1998). II presente volume, che raccoglie i contributi di alcuni tra i più autorevoli specialisti a livello internazionale, permette al lettore di scendere in profondità in quel nodo della storia che sono stati gli anni venti e trenta nella Russia sovietica, di riconoscere in mezzo alla follia totalitaria l'emergere della coscienza (dall'umile grandezza del patriarca Tichon alla teologia di Florenskij, Bulgakov, Lossky, alla poesia di Achmatova e Pasternak), di ascoltare nell'esile voce di coloro che non rinunciarono alla propria umanità la forza di un senso che libera per la vita. "La testimonianza silenziosa di centinaia di migliaia di uomini e donne appartenenti a tutte le confessioni cristiane, ma soprattutto a quella ortodossa, che hanno accompagnato e condiviso in tutto la sofferenza e l'angoscia del popolo russo ... è stata un magistero silenzioso ma eloquente di come i cristiani possono vivere nella storia senza esenzioni, nella compagnia degli uomini, portandone i pesi, ma al tempo stesso essendo portatori di una speranza che non è di questo mondo ... dono all'umanità tutta alla ricerca di un senso al proprio vivere e soffrire"
Per ordinare
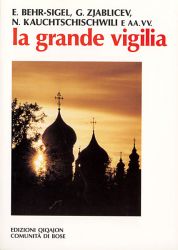
V Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
La grande vigilia
Bose, 17-20 settembre 1997
La Santa Russia, tra la fine del XIX secolo e la Rivoluzione d'ottobre, vive un'ora carica di profezia, un tempo di Vigilia, in cui, nello smarrimento delle coscienze, ai cristiani è chiesto di discernere la qualità della loro attesa. L'esperienza di chi - come il vescovo Ignatij Brjancaninov, Teofane il Recluso, loann di Kronstadt e gli ultimi starcy di Optina - seppe confessarsi fedele alla terra e insieme straniero, pellegrino verso il Regno, indica nella Vigilia un tempo e un luogo: attesa che separa la storia dalla parusia, e spazio della testimonianza cristiana finché il Signore venga. I saggi del volume, presentati al V Convegno internazionale di spiritualità russa, sono un'occasione per guardare a quest'epoca travagliata attraverso il prisma della santità, un invito alla riflessione su alcuni nodi chiave per la storia e l'autocoscienza spirituale dell'occidente e dell'oriente contemporanei.
Per ordinare
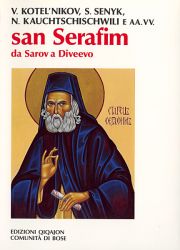 IV Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
IV Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
San Serafim. Da Sarov a Diveevo
Bose 18-21 settembre 1996
Di Serafim di Sarov (1759-1833), il più amato e venerato di tutti i santi russi, è noto il Colloquio con Motovilov, sintesi del suo luminoso insegnamento sull'azione dello Spirito in noi. Ma l'influenza di quest'umile starec ha conosciuto un'irradiazione vastissima nella chiesa come nella società, fino a trovar eco nel pensiero dei grandi maestri della teologia ortodossa contemporanea. Le relazioni presentate al IV Convegno ecumenico internazionale di spiritualità russa restituiscono l'autentico profilo storico e spirituale di san Serafim di Sarov e offrono un avvincente spaccato della condizione del monachesimo e della chiesa in Russia, dalla secolarizzazione settecentesca alla vigilia della rivoluzione d'ottobre. In "Appendice" il testo integrale della più antica Vita dello starec Serafim.
Per ordinare
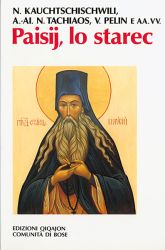 III Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
III Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
Paisij, lo starec
Bose, 20-23 settembre 1995
A Paisij Velikovskij (1722-1794) risale quel movimento di rinnovamento del monachesimo e della vita cristiana nell'Europa orientale nella seconda metà deXVIII secolo che avrebbe profondamente segnato la cultura e la spiritualità russa del secolo successivo, da Gogol' a Dostoevskij, da Kireevskij a Leont'ev, a Lev Tolstoj e all'anonimo autore dei Racconti di un pellegrino russo. Di Paisij le testimonianze ricordano la particolare dolcezza e sapienza nel guidare i fratelli: con lui rifiorisce in oriente la preghiera di Gesù e si riannoda l'antica tradizione della paternità spirituale; al suo nome è legata la versione slava della Filocalia, la fondamentale antologia dei padri orientali sulla preghiera del cuore. Il volume, che raccoglie i contributi del Terzo convegno ecumenico internazionale di spiritualità russa, offre al lettore una messa a punto dello stato della ricerca sull'opera paissiana e il movimento filocalico, e restituisce il profilo spirituale dello starec che, in un tempo di guerre e tensioni tra nascenti nazionalismi, seppe attraversare i confini e unire in una stessa avventura uomini lontani nello spazio e nel tempo.
Per ordinare
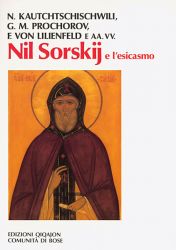 II Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
II Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
Nil sorskj e l'esicasmo
Bose, 21-24 settembre 1994
II volume raccoglie gli interventi presentati in occasione del Il Convegno ecumenico internazionale di spiritualità russa, dedicato a Nil Sorskij e I'esicasmo (Bose, settembre 1994). Queste pagine consentono al lettore di evocare in una prospettiva nuova l'epoca cruciale della Rus' tra il xv e il xvi secolo, tempo di crisi e d'inquietudine in cui visse Nil, il solitario della Sora. La sua fuga dal monachesimo ricco di beni del suo tempo, inaugura nella storia della spiritualità russa, la vita monastica dello skit, vita di silenzio con un ristretto numero di fratelli. II lettore potrà così misurare l'impatto storico dell'insegnamento del grande starec, presso i contemporanei e presso uomini apparentemente separati da un'incolmabile distanza geografica, cronologica, confessionale. Nil non dice cose nuove; uomo delle fonti, attinge abbondantemente alla Scrittura e ai padri; ma le cose "antiche" le rende nuove, levigate, trasparenti, perché le sa irrigare con una grande paternità spirituale, un gusto dell'eterno in grado di attrarre fortemente l'uomo d'oggi.
Enzo Bianchi
Per ordinare
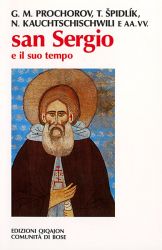 I Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
I Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa
San Sergio e il suo tempo
Bose, 15-18 settembre 1993
San Sergio di Radonez sta all'inizio della storia nazionale russa ed è la prima radice della grande e radiosa spiritualità della "Santa Russia". Con la figura di san Sergio si sono anche inaugurati, nel settembre 1993, gli incontri di studio sulla spiritualità russa presso la Comunità monastica di Bose. La santità russa è essenzialmente espressione di carità: è una storia di martiri che perdonano, che non chiedono mai vendetta. San Sergio pregava perché il mondo lacerato dall'odio fosse riempito di quell'amore che regna in seno alla comunità della Trinità vivificante. È la visione del mondo di cui seppe così fedelmente farsi interprete Andrej Rublev nelle sue icone, in particolare in quella di tutta la creazione che si rallegra nella Madre di Dio: terra redenta, creatura rappacificata, tempio di nuovi cieli e nuova terra, finalmente in piena comunione. Il mondo lacerato di cui era stato testimone san Sergio diventa la casa di Dio.
Enzo Bianchi
Per informazioni sui convegni scrivere o telefonare a:
Segreteria Convegni
Monastero di Bose
I-13887 Magnano (BI)
Tel. +39 015.679.185
Fax +39 015.679.294
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.